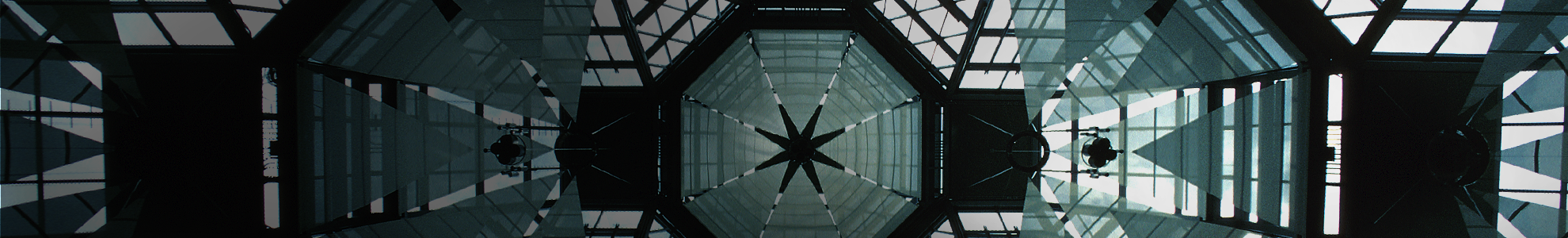di Redazione OAR
Accedere a maggiori opportunità di lavoro, su tipologie di interventi più varie e dinamiche. Sfruttare procedure autorizzative rapide e snelle, più certezze di portare a compimento i progetti, un approccio da parte della committenza efficace e pragmatico. Ma anche adeguarsi ad una scelta obbligata in un mercato ormai del tutto globalizzato.
Sono alcuni dei motivi che spingono molti studi di architettura italiani e, nello specifico, romani, a guardare con crescente interesse oltre i confini nazionali per sviluppare il proprio percorso professionale. Del tema internazionalizzazione abbiamo parlato con due professionisti, entrambi partiti da Roma, che hanno adottato approcci diversi verso il mercato estero, ma i cui destini si sono incrociati, trovando in Svezia un punto d’incontro comune: Alessandro Ripellino e Luigi Pardo sono gli architetti che – con i loro studi, Alessandro Ripellino Arkitekter e Luigi Pardo Architects (LPA), insieme allo studio parigino Adrien Gardère (sempre per un “tramite” italiano: l’architetto Francesca Galdangelo) – hanno firmato “The Forest” (https://www.government.se/articles/2018/12/the-swedish-pavilion-at-expo-2020-in-dubai-the-forest/), il progetto per il padiglione svedese per Expo 2020 a Dubai, scelto da una giuria composta dall’Architects Sweden, l’ordine professionale che raggruppa gli architetti delle diverse specializzazioni, e dal comitato per la partecipazione della Svezia all’esposizione universale.
Alessandro Ripellino – 62 anni, laureato in architettura alla Sapienza – ha stabilizzato il proprio studio (circa 25 dipendenti, più diversi collaboratori) a Stoccolma, dopo aver scelto la capitale svedese come base per lo sviluppo della propria attività. Lo studio guidato da Luigi Pardo (33 anni), invece, è una realtà più giovane (3 persone fisse con collaboratori) con sede a Roma ma con un flusso di attività proiettato con crescente interesse verso l’estero.
Iniziamo raccontando le vostre scelte professionali: le motivazioni alla base della decisione di trasferirsi all’estero o, comunque, di rivolgersi sempre più al mercato internazionale.
Ripellino: Il mio percorso professionale è frutto di un mix di fattori personali e professionali. Durante gli studi, nel 1980, ho incontrato a Parigi mia moglie, svedese, e – in seguito – sono andato a Stoccolma a studiare la lingua, prendendo contatto con la Facoltà di Architettura del Politecnico (KHT), ottenendo una borsa di studio. Poi ho iniziato a lavorare in uno studio in Svezia, toccando con mano una realtà in continua espansione, con l’aumento demografico e lo spostamento verso le città che offrono opportunità enormi rispetto all’Italia. I meccanismi politici e la committenza, sia pubblica che privata, sono estremamente efficaci e “pragmatici”. Si va avanti velocemente, a volte troppo. C’è spazio, se si è capaci si fa strada.
Pardo: La nostra sede è a Roma e stiamo aprendo uno studio a Catania, dove attualmente abbiamo diversi progetti. Ma il guardare fuori dai confini del nostro Paese è una scelta ormai obbligata tenendo conto di un mondo ormai quasi del tutto globalizzato. Per chi può, lavorare con l’estero significa anche avere opportunità più varie e dinamiche. Cambiano i gusti dei committenti, le tipologie di edifici, il modo di progettare per adattarsi al luogo: può essere un rischio ma anche un ottimo allenamento intellettuale e progettuale, se piacciono le sfide. Per quanto riguarda il legame con la Svezia, nello specifico, anche nel mio caso c’è una motivazione personale: mia moglie è svedese di nascita.
Il “valore” del progetto all’estero è diverso da quello che assume in Italia? E il rapporto con la committenza?
R.: All’estero, e in Svezia in particolare, si lavora in modo diverso. Gli architetti hanno raramente la responsabilità totale del costo del progetto. Alla maniera americana, c’è un project leader, spesso un economo che ha la responsabilità del budget. I consulenti tecnici sono incaricati direttamente dal committente e lavorano parallelamente all’architetto, il quale deve sapere gestire la comunicazione sia con il cliente, i suoi rappresentanti e utenti, che con il project leader. Si lavora in un team con gerarchia abbastanza piatta. Gli imprenditori edili sono spesso incaricati con il ruolo di “total contractor”. Per un italiano è una situazione difficile, con meccanismi e codici diversi da quelli ai quali è abituato, per entusiasmare, convincere e guidare il gruppo. Il valore aggiunto che un progettista italiano può esportare è la sua formazione ampia. Qui in Svezia, direi, è abbastanza superficiale. Poca conoscenza tecnica e strutturale, poca storia dell’architettura e urbanistica.
P.: Forse, più che altro, cambia il valore che il committente dà al progettista, che in Italia è spesso una figura incompresa: il lavoro fatto bene passa spesso inosservato, mentre l’errore salta subito agli occhi. In Svezia, ma anche in altri Paesi, si dà davvero importanza al progetto che, oltre alla forma, viene concepito – soprattutto – come un processo importante per cambiare lo stato delle cose, sia a piccola che a grande scala.
In Italia lo strumento del concorso di progettazione fa molta fatica ad ingranare. All’estero va meglio?
R.: In Svezia, per andare sul concreto, ci sono concorsi di tipo diverso, quelli controllati dall’associazione degli architetti svedesi funzionano in maniera discreta, ma anche qui ci sono fenomeni sgradevoli, tipo che il committente cambi l’architetto dopo il concorso. Il tipo peggiore di concorso è il cosiddetto “incarico parallelo”, non controllato dall’associazione.
P.: Purtroppo, anche rispetto alle normative europee, per un giovane studio sta diventando sempre più difficile accedere ai concorsi di progettazione. Che invece rappresentano uno strumento importantissimo, sia per il confronto che per la qualità del progetto: il nostro studio cerca di farne il più possibile.
Come è nata la collaborazione sul progetto per il padiglione svedese per Expo 2020?
R.: Ho conosciuto Luigi Pardo diversi anni fa e abbiamo fatto insieme prequalificazioni per concorsi, ad esempio per Bari Centrale, sino a quello per il Padiglione svedese a Dubai. La collaborazione attuale per Expo ha un collegamento ‘tutto italiano’ in campo europeo.
P.: I progettisti italiani hanno enormi capacità, ma tra queste purtroppo non c’è quello di fare sistema – non in Italia. Viaggiando molto invece mi capita di incontrare connazionali con un diverso background ma con la stessa voglia di fare squadra. L’Expo 2020 ha un “filo rosso” tutto italiano: in ogni studio abbiamo degli elementi italiani, contatti che sono stati l’inizio della collaborazione tra le tre diverse realtà.
Dialogo aperto con gli studi romani. La redazione OAR si confronta sul futuro della professione raccogliendo e raccontando progetti e riflessioni degli #architettiromani
#PHOTO GALLERY