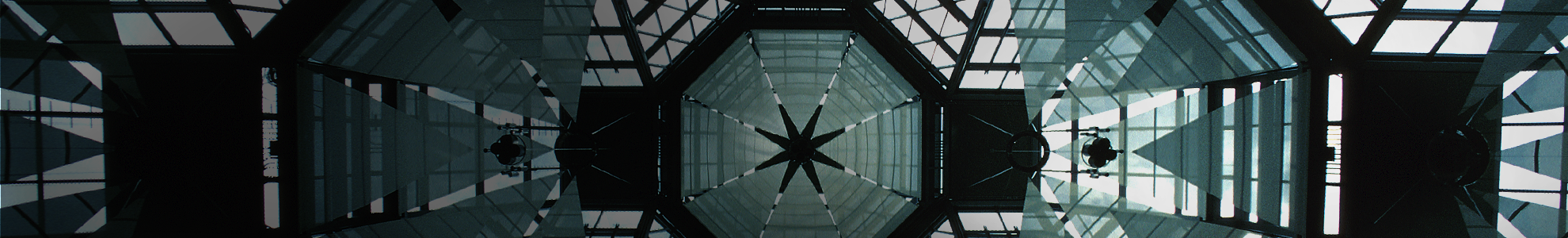di Redazione OAR
Un’attenzione al paesaggio che è un atto di responsabilità nei confronti del nostro habitat. Questa la sensibilità con cui Franco Zagari si pone dinnanzi alla sua professione, che è un inno alla libertà ed alla sperimentazione architettonica. Ha insegnato ad intere schiere di architetti, anche grazie alla sua docenza universitaria, che il progetto non deve contemplare il solo edificio, ma lo spazio nella sua interezza, al di là del singolo oggetto architettonico, del naturale o dell’artificiale. Possiamo definirlo un Maestro del Paesaggio con il merito di aver dato dignità e valore alla materia.
Architetto Zagari, quali sono gli ingredienti fondamentali per un buon progetto di paesaggio?
Ogni progetto di paesaggio è diverso: niente è più atipico. Ogni progetto, dalla corolla di un fiore ad un ambito di scala vasta, deve essere un processo il più possibile aperto, concertato e partecipato dalla fase di ideazione alla conclusione dei lavori ed oltre, all’esercizio. Una sintesi di diagnosi e interpretazione dei contesti, una continua dialettica fra valori etici, estetici, di conoscenza. La bellezza, senza mezzi termini dev’essere il nostro primo obiettivo. Segue un intento politico come dice Anish Kapoor e poi il lavoro che dev’essere posto accanto alle opere come una condizione di crescita tale da garantire la futura gestione, la benedetta governance, da affiancare ai fenomeni della trasformazione del territorio. Fra gli “ingredienti” citerei senz’altro un riavvicinamento fra la consapevolezza delle proprie radici storiche e la capacità di guardare il futuro con creatività e competenza.
Architettura del paesaggio e del costruito sono in antitesi o in astratta connessione?
Non hanno alcuna differenza: ci sono paesaggi lapidei meravigliosi e luoghi naturalistici noiosi e stantii. Naturalmente dovremo lavorare non solo per non incrementare le aree costruite, ma anche per moltiplicare il recupero di aree verdi nelle zone già costruite. In fondo l’edificato e lo spazio libero tra di esso sono due diverse espressioni di uno stesso fenomeno chiamato antropizzazione. Le due polarità dovrebbero essere sottratte ad un confronto ostile e divenire sintesi di valori. Patrimonio e sostenibilità sono cose troppo serie per essere bruciate con dei luoghi comuni conservatori.
Nella sua carriera con quale tipo di committenza si è rapportato?
Difficilmente io ho cercato i miei clienti: sono loro che mi hanno chiamato proponendomi delle collaborazioni, almeno quando c’era un mercato e una certa fluidità fra i diversi ambienti di lavoro. Il mio rapporto è stato generalmente molto buono, ma con il passare del tempo sempre più complesso, più complicato, oltre che più conflittuale. I motivi sono tanti: la mancanza di coesione fra i professionisti e di una politica concordata di offerta all’estero, la crescente burocrazia che, anche in casi di colleghi architetti amministrativi veramente encomiabili, ha prodotto nel tempo delle procedure di controllo e di valutazione sempre più strumentali. Essere competitivi e attraenti credo che dipenda dall’onestà con la quale si sanno impostare i problemi con modalità che siano favorevoli per i committenti, sempre che questi perseguano degli obiettivi condivisibili.
Come è riuscito ad internazionalizzare la sua professione?
Cerco per quanto è possibile di differenziare gli ambiti geografici e politici dove intervengo. Ho sempre imparato molto lavorando all’estero e credo che il mercato libero, trasparente e vivace, anche se sembra un’utopia, esista, così come esiste anche un modo per indirizzare le proprie energie verso dei paesi che riteniamo affini alla nostra cultura e alla nostra capacità di ascoltare e capire l’altro da sé.
Essere accattivanti professionalmente significa saper dimostrare fantasia e competenza. Uno dei paesi dove ho lavorato più volentieri è stato il Giappone, per cinque anni di seguito avanti e indietro. La regola è sempre la stessa: sedersi su una panchina, osservare e ascoltare.
Non bisogna tuttavia pensare che lavorare nel proprio Paese sia meno interessante. Molto stimolante è stato per me anche il coordinamento, affidatomi dal Comune di Roma, di un gruppo per il recupero del Centro Giano sull’Ostiense, “Zone O” o, come si diceva, “spontaneamente sorta”.
La lottizzazione abusiva era concepita in maniera molto saggia: il costruito e il non costruito disegnavano uno spazio urbano umano, proporzionale alle loro risorse auto-costruttive. Il merito di questo equilibrio era avere ignorato le regole degli standard e dello zonizzazione. Poi il progetto fu martoriato da prescrizioni che caddero nel vuoto, come la rimozione delle recinzioni e di parte dei giardini privati per avere vie “a norma” che non servivano a nessuno. La storia ha fatto il suo corso e ha espresso il suo giudizio.
Cosa ne pensa delle procedure concorsuali?
Il concorso dovrebbe essere adottato per questioni che riguardano tematiche particolari, su cui un consulto risulti significativo, oppure per determinate finalità come la sperimentazione o il lancio di giovani generazioni. Non sono affatto contrario all’incarico diretto, quando questo sia dovuto a motivi ragionevoli, che non sono certamente un incoraggiamento del nepotismo, più di quanto in realtà già accada ora.
Opportunità e criticità dell’architettura del paesaggio?
Le opportunità sono virtualmente infinite. Sono convito che molte opere di architettura del paesaggio costerebbe meno costruirle che non costruirle. Se accostati con una nuova mentalità alcuni progetti possono aprire dei processi di sviluppo spontaneo molto interessanti. Il mercato deve in questo momento essere rifondato e credo che spetti soprattutto ai giovani, non necessariamente dell’età di Greta, ma non molto più vecchi.
Giovane non è necessariamente bello, ma sono diverse mentalità e abitudini, che generano una scomposizione e ricomposizione dei temi che ci sono proposti.
Ci lamentiamo di essere troppi architetti, fissandoci su dei dati materiali e statistici invece che sulla qualità, quella vera, quella che rende. Le opportunità stanno nel “saper vedere”, saper cogliere le vocazioni e l’evolvere dei luoghi, stabilire principi di orientamento e qualità di nuova centralità negli insediamenti suburbani. Le opportunità stanno nel favorire e promuovere ovunque sia possibile la funzione dell’architetto che parte dalla capacità di sviluppare un dialogo.
I suoi progetti più rappresentativi?
Li ritengo tutti ugualmente rappresentativi: sono creazioni che sono state tutte molto amate, anche le più sfortunate. Se dovessi citare un progetto di cui ho nostalgia, visto che attualmente non ho occasione di vederlo se non con Google, direi la cupola della Presidenza della Repubblica della Georgia a Tblisi, fatta con Vato Zesashvili.
Dialogo aperto con gli studi romani. La redazione OAR si confronta sul futuro della professione raccogliendo e raccontando progetti e riflessioni degli #architettiromani
#PHOTO GALLERY